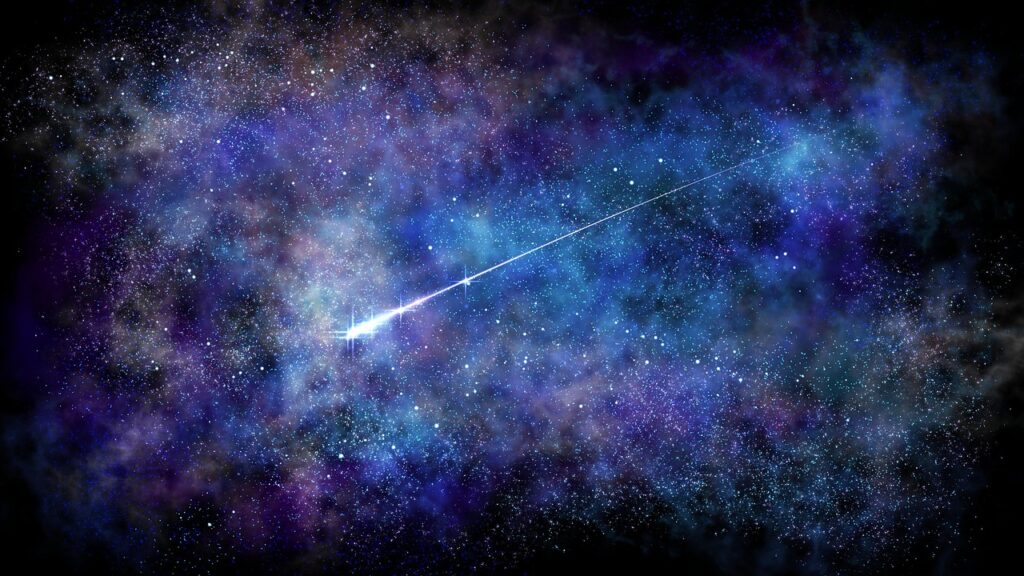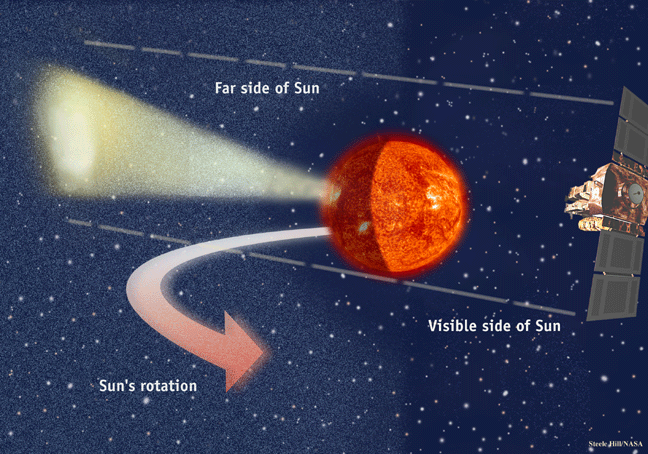La tanto attesa cometa Swan sta per illuminare i nostri cieli.
La cometa, ufficialmente designata C/2025 F2 e popolarmente chiamata “cometa del primo maggio”, è stata scoperta tra il 29 e il 31 marzo 2025 grazie alle immagini raccolte dallo strumento SWAN (Solar Wind Anisotropies) a bordo della sonda SOHO. Si prevede che raggiungerà il perielio il 1° maggio, avvicinandosi tanto al Sole da trovarsi appena all’interno dell’orbita di Mercurio, e che la sua luminosità possa arrivare a una magnitudine di circa +5, rendendola visibile ad occhio nudo se le condizioni di cielo saranno favorevoli.
Al momento la cometa è già stata individuata nelle prime luci dell’alba, comparendo nella costellazione di Andromeda, e da fine aprile si prevede che diventi visibile anche in orario serale, posizionandosi nell’orizzonte ovest tra le costellazioni del Perseo, Triangolo e Toro. Un fatto particolarmente interessante è la sua orbita estremamente eccentrica e la sua inclinazione di 90° rispetto al piano dell’eclittica: questa geometria significa che gli osservatori dell’emisfero boreale potranno godere di una visione migliore nelle ore precedenti il perielio, mentre chi si trova nell’emisfero australe potrà ammirarla appieno successivamente.
Un ulteriore elemento affascinante riguarda il colore della sua chioma, che assume una tinta verde dovuta all’emissione delle bande della molecola di di‐carbonio. Anche se attualmente la cometa brilla con una magnitudine intorno a +7,5, gli osservatori hanno già notato un outburst, ovvero un improvviso aumento di luminosità, avvenuto il 5 aprile, che fa sperare in uno spettacolo sempre più sorprendente man mano che ci si avvicina al perielio.
Questo evento celeste rappresenta un’opportunità straordinaria per gli appassionati di astronomia: preparare un piccolo telescopio o un buon paio di binocoli, trovare un luogo con un orizzonte sgombro dall’inquinamento luminoso e magari svegliarsi un po’ prima dell’alba per assistere a questa raro fenomeno. Osservare una cometa di tale portata, il cui periodo orbitale si stima attorno ai due milioni di anni, è un’occasione davvero unica per connettersi con i misteri dell’universo.
Il telescopio SWAN
Il telescopio SWAN, acronimo di Solar Wind ANisotropies, non è un telescopio convenzionale, bensì un sofisticato strumento per l’osservazione in ultravioletto montato sulla sonda SoHO (Solar and Heliospheric Observatory) della NASA. Progettato per rilevare le deboli emissioni della linea Lyman‑α (a circa 121,6 nm), SWAN è particolarmente efficace nel mappare la distribuzione degli atomi di idrogeno neutri in prossimità del Sole.
Questo è fondamentale perché, quando una cometa come la C/2025 F2 (nota come Cometa Swan) si avvicina al Sole, il riscaldamento provoca la sublimazione dell’acqua contenuta nel nucleo, liberando idrogeno che, interagendo con il fotone solare, emette in ultravioletto. In questo modo, SWAN riesce a catturare un “impronta” luminosa della cometa sotto forma di una vasta chioma di idrogeno, anche quando l’oggetto non è ancora particolarmente brillante negli spettri ottici.
Lo strumento presenta un ampio campo visivo e una sensibilità tale da coprire vaste porzioni del cielo, permettendo così agli astronomi di monitorare non solo la presenza di comete ma anche le dinamiche del vento solare e le interazioni tra quest’ultimo e il materiale espulso dalle comete. Questa doppia funzione, quella di studiare il vento solare e quella di identificare eventi transitori come l’arrivo delle comete, rende SWAN uno strumento prezioso nell’arsenale degli osservatori spaziali.
Oltre all’osservazione in ultravioletto, i dati raccolti da SWAN si integrano con quelli provenienti da telescopi ottici e strumentazioni spettroscopiche, offrendo una visione completa degli oggetti celesti. Tale approccio multi-spettrale permette di decifrare in maniera più approfondita la composizione chimica e la dinamica evolutiva delle comete, contribuendo a comprendere meglio sia il loro comportamento che il modo in cui interagiscono con l’ambiente solare.
I dati raccolti dallo strumento SWAN vengono impiegati in astronomia per studiare in maniera approfondita le proprietà fisiche e chimiche delle comete. Ecco alcuni degli utilizzi principali:
- Monitoraggio della produzione d’acqua: SWAN rileva le emissioni nella linea Lyman‑α, prodotte dall’idrogeno neutro che si libera quando l’acqua presente nel nucleo cometario si sublima e poi si dissocia. Misurando la distribuzione e l’intensità di questa radiazione ultravioletta, gli astronomi possono stimare la quantità di acqua rilasciata dalla cometa, ottenendo così informazioni preziose sul tasso di sublimazione del nucleo e sulla sua attività globale.
- Individuazione di fenomeni transitori: L’alta sensibilità e il campo visivo esteso di SWAN permettono di identificare rapidamente variazioni nell’intensità della luce ultravioletta, come quelle che accompagnano eventi di “outburst” — improvvisi aumenti di attività che possono causare un temporaneo incremento della luminosità della cometa. Questi dati in tempo reale sono fondamentali per coordinare osservazioni da altri strumenti e telescopi, ottimizzando la raccolta di informazioni durante questi episodi dinamici.
- Analisi dell’interazione con il vento solare: La chioma di idrogeno che circonda una cometa non solo è il risultato della sublimazione, ma è anche influenzata dal vento solare. I dati di SWAN consentono di studiare come il vento solare interagisca con questo materiale, modificando la forma e l’estensione della chioma. Queste informazioni aiutano a comprendere meglio la dinamica del plasma e le condizioni del mezzo interplanetario.
- Integrazione in studi multi-spettrali: I profili di emissione ottenuti in ultravioletto da SWAN vengono spesso confrontati e integrati con dati provenienti da osservazioni in altri range spettrali (ottico, infrarosso, radio). Questo approccio multi-spettrale permette agli astronomi di ottenere un quadro completo della struttura, composizione e evoluzione delle comete, mettendo in relazione i fenomeni fisici osservati a diverse lunghezze d’onda.
In sintesi, i dati di SWAN non solo facilitano la scoperta di nuove comete (come la C/2025 F2, detta “Swan”), ma forniscono anche dettagli essenziali per studiare i meccanismi di attività cometaria e l’interazione con l’ambiente solare, contribuendo in modo significativo alla nostra comprensione dei processi che regolano l’evoluzione dei corpi del Sistema Solare.